
In occasione del 172. anniversario della nascita di Henryk Sienkiewicz (5.05.1846-15.11.1916) – Premio Nobel per la letteratura 1905 – presentiamo ai nostri lettori di lingua italiana l’articolo di A. Koltonski dedicato al celebre scrittore polacco, pubblicato nel febbraio 1917 sulla rivista italiana EMPORIUM (Vol. XLV nr 266).
L’articolo originale è consultabile sul sito http://www.artivisive.sns.it.
A.R.B.
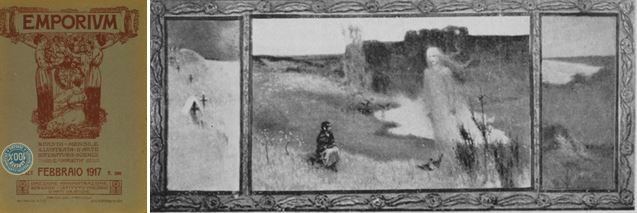
HENRYK SIENKIEWICZ
L’anima di un popolo parla attraverso i suoi poeti.
A Vevey, sul lago di Ginevra, suonano le campane. Sono le campane della morte. Le onde azzurre riprendono il loro suono triste e dalla solitudine del lago il vento portalo sulle sue ali rapide lontano lontano nel mondo insanguinato. È morto Enrico Sienkiewicz.
È morto il grande scrittore polacco. Chi non conosce il nome suo, a chi ignote sono le pagine deliziose dei suoi romanzi, stampati e ristampati in tutte le lingue civili?
Enrico Sienkiewicz iniziò la sua carriera di scrittore in un momento non troppo propizio alla letteratura polacca. Sotto il soffio della filosofia materialista e delle lotte economiche, accesesi sull’orizzonte europeo, ma anzitutto sotto l’influenza del tragico fallimento del romanticismo politico, la letteratura polacca di quell’epoca diventò troppo tendenziosa e troppo invasa dai problemi grigi della vita quotidiana.
Come tanti altri suoi contemporanei, Sienkiewicz, ancora studente della famosa Szkola Główna diventata in seguito l’Università Imperiale di Varsavia, comincia, scrivendo sotto il pseudonimo di Litwos delle appendici e delle cronache per uno dei più rinomati quotidiani della capitale, senza però risvegliare un interesse speciale nel largo cerchio dei suoi abbonati.
Inosservati quasi dal gran pubblico passano pure i primi suoi romanzi. Ma verso il 1875 Sienkiewicz si dedica alla novella ed è da allora che la curva della sua fama comincia a descrivere una linea sempre più ascendente.
Un lirismo indefinibile, attraverso il quale si sente appena appena qualche triste nota di un pessimismo melanconico, fa di queste novelle dei veri gioielli. Qui appartiene l’insuperabile «Bartek il Vincitore» e il meraviglioso «Janko il Musicista», che suonano come dei rimproveri amari fatti dal loro autore all’indifferenza e all’egoismo delle classi intellettuali. Qui appartengono pure «Il vecchio domestico», «Hania» e tanti altri ancora.
Ma ecco, attirato dall’ignoto dei mondi lontani, Sienkiewicz abbandona la patria e va in America, da dove invia le sue «Lettere dal viaggio», magnifiche impressioni di uno spirito vivo e sottile.
Rimpatriato, dopo una lunga assenza, torna al giornalismo, scrive nuovamente delle novelle e tenta – ma senza nessun successo – di provare le sue ali anche nella commedia. Sotto l’influenza delle reminiscenze americane avviene però in lui una trasformazione inaspettata. Il difensore positivista del progresso, tornato dal paese più democratico della terra, volge lo sguardo innamorato sempre di più verso gli ideali conservatori del passato, nel quale l’anima sua poetica scopre finalmente un vero mondo dei suoi sogni e pensieri.

Nel 1883 due giornali contemporaneamente – uno a Varsavia e l’altro a Cracovia – cominciano a pubblicare nell’appendice il romanzo «Col Ferro e col Fuoco», seguito, a breve distanza, da due altri: «Il Diluvio» e «Messire Wolodyjowski» – una trilogia. Fu una vera rivelazione. Un capitolo – sicuro uno dei più eroici e più ricchi negli avvenimenti drammatici della storia polacca – rinchiuso dal poeta in un magnifico trittico, convinse fin dalla prima battuta il mondo intiero. Fu un soffio potente, una rianimazione del romanzo storico, diventato, grazie all’infelice scelta dei temi e mancanza di giusta prospettiva, vuoto e noioso.
La seconda meta del secolo XVII, piena di contrasti, di grandi cataclismi politici e continue guerre, che attraverso i più terribili sbalzi del destino, finirono colla completa vittoria delle armi polacche – ecco la fonte d’ispirazione della trilogia. Le lotte ucraine nel «Col Ferro e col Fuoco», l’invasione degli svedesi nel «Il Diluvio» e quella dei tartari nel «Messire Wolodyjowski» rappresentano il suo fondo plastico e pittoresco, nel quale gli assedi di Zbaraz, di Czenstochowa e di Kamieniec formano i tre punti centrali, attorno ai quali Sienkiewicz, con una maestria insuperabile, racconta la grande epopea del suo popolo – i momenti più tragici della Repubblica e la miracolosa sua salvezza.
Una ricchezza inesauribile delle concezioni e delle figure, dipinte attraverso un mirabile velo di un romanticismo sincero ed una fantasia fresca che non tollera nessuna ripetizione, nessuna banalità, fanno della trilogia un vero capolavoro dell’arte narrativa e giustificano pienamente il grande successo non solo in patria del suo autore, ma anche fuori, presso gli stranieri. Bisogna però esser polacco per comprendere tutta la grandiosità e tutta la bellezza di quest’opera, unica nel suo genere nella letteratura mondiale. Rievocando – pur tenendo aperti gli occhi anche sugli errori – le glorie secolari della patria, Sienkiewicz appare nella Trilogia come un vero apostolo del più puro e più nobile sentimento patriottico.

Come una vera reazione, avvenuta nell’anima del poeta, sembra dopo la Trilogia il suo «Senza Dogma». Sienkiewicz, come se fosse stanco delle guerre e delle lotte, da lui con tanta forza descritte e quasi vissute, abbandona il passato per il presente e dai grandiosi quadri di una visione storica passa senz’altro alla minuziosa analisi psicologica di un individuo solo. Il suo Ploszowski, l’eroe del racconto, è un nevrastenico, un uomo sposato, un dilettante che si perde continuamente in un’autoanalisi disanimante, un tipo, per il quale la vita non è che un passatempo inutile e noioso, di cui soluzione definitiva trova nella palla di una revolverata. Fu un tema nuovo per la letteratura polacca, che ebbe però anche all’estero il suo successo meritato, tanto per la profondità dei pensieri quanto per la sua forma perfetta ed originale.
In vero contrasto con quest’ultima opera di Sienkiewicz si trova «La Famiglia Polaniecki», fra i suoi romanzi forse il più debole. Esso apparve veramente un po’ fuori tempo, come una reminiscenza di un’epoca già sbiadita. Ciò nondimeno, il romanzo possiede tutte le qualità di un’opera squisitamente bella e non comune.
Mentre Sienkiewicz scrive ancora ogni tanto delle bellissime novelle e delle interessantissime lettere – questa volta dall’Africa – un mondo completamente nuovo occupa già la sua mente viva ed irrequieta. Roma antica, ma specialmente Roma di Nerone, con tutti i contrasti della sua vita catastrofica, con tutta l’immensità dei suoi avvenimenti e tutta la bellezza del suo sfondo pittoresco e grandioso, attrae con una forza irresistibile la fantasia del poeta. Collo zelo di un archeologo autentico egli studia la topografia della città eterna, fruga nella sua storia e ricostruisce l’impotente quadro dell’antica sua grandezza. E così piano, piano proceduto dal «Seguiamolo!», nasce il «Quo Vadis?», l’opera che col lauro cinse le tempie del grande scrittore polacco.
Delle origini del suo «Quo Vadis? parla Sienkiewicz stesso in una lettera, scritta nell’anno 1896 e pubblicata ultimamente dal «Gaulois». «Da anni – dice la lettera – avevo l’abitudine di leggere, prima di addormentarmi, gli storici latini tanto per la storia, che m’interessava per se stessa infinitamente, quanto per la lingua, che non volevo dimenticare. Questa abitudine ha risvegliato in me un amore sempre crescente per il mondo antico. Tacito era il mio storico prediletto. Leggendo gli «Annali» mi sentivo spesso attratto dall’idea di contrapporre in un’opera d’arte due mondi: quello della potenza governante e della macchina amministrativa più forte del mondo e quello che rappresentava solo una forza spirituale. Come polacco, mi tentava l’idea della vittoria dello spirito sulla materia, come artista l’ammirabile ricchezza formale del mondo antico. Sett’anni or sono, epoca del mio ultimo soggiorno romano, visitavo la città eterna e i suoi dintorni con Tacito alla mano. Posso dire che l’idea era già matura: non si trattava che di trovare il punto di partenza. Me lo diedero alla cappella del «Quo Vadis?», la Basilica di S. Pietro, le Tre Fontane, i monti albani. Tornato a Varsavia, cominciai gli studi storici i quali crebbero l’amore del soggetto. Questa è la genesi del «Quo Vadis?». Quanto vi scrivo e troppo secco e breve. Bisognerebbe aggiungervi i miei sentimenti personali, le visite alle catacombe, il luminoso paesaggio che circonda sempre la città eterna, e gli acquedotti veduti all’alba o al tramonto…»
Fuori della patria e presso la moltitudine la fama di Enrico Sienkiewicz resterà sempre unita al suo «Quo Vadis?» – l’apogeo della sua gloria e della sua arte. rivelato al mondo in un momento veramente favorevole, quando il pubblico annoiato completamente dagli ultimi sussulti delle banalità naturalistiche, sentì già i primi aliti del neocristianismo, questo romanzo meraviglioso ebbe la fortuna mai superata da nessun’altra opera letteraria. Rappresentando tanto per la scelta dell’argomento che per la forza artistica e fondo morale una fonte ricchissima delle sensazioni molto forti, esso ipnotizzò le grandi masse di tutti i paesi colla semplicità della sua lingua chiara e quadrata, coi colori smaglianti delle magnifiche sue descrizioni, colla sapiente distribuzione delle ombre e delle luci e la genialissima contrapposizione di due mondi così maestrevolmente ricostruiti, ma anzitutto colla teatralità e, diciamolo pure, spettacolosità dei suoi quadri maestosi, che, come certi grandiosi affreschi del passato, posseggono nel loro fascino irresistibile il segreto della convinzione. È vero che il «Quo Vadis?» non trovò una simile fortuna anche tra gli intellettuali, gli elementi però che lo rendono così universalmente comprensibile gli danno pure l’incontestabile valore d’un capolavoro immortale.
Come delle figure indimenticabili passano davanti a noi i personaggi di questo romanzo esemplare, come se fossero scolpiti tutti di una roccia dalla mano sicura di qualche scultore divino. Tanto la pallida Ligia, nell’angelica sua bellezza, figlia soave di una lontana stirpe regale, quanto il Vinicio, quel tipico romano colla lenta e meravigliosa trasfigurazione della sua anima pagana, che avviene in lui sotto la luce miracolosa della nuova religione; Petronio, arbiter elegantiarum, esteta e stoico – prodotto più raffinato della cultura antica, ed Eunice, la sua amante bella e voluttuosa; Pietro e Nerone, quest’ultimo anzi tutto, un commediante e cinico sul trono inaccessibile dei Cesari, che, colla perversa gioia di un pazzo degenerato, fa accendere torcie vive nei viali dei propri giardini, s’inebbria nel circo alle torture dei martiri cristiani, sbranati dalle belve inferocite, oppure, cantando, contempla attraverso una caramella d’ametista le bellezze della città eterna in fiamme.
Ma anche le figure secondarie – il gigante Ursus, protettore devoto di Ligia, figlio smarrito della stessa terra schiava, e Glauco, e Popea, e il farabutto Chilone, pauroso, e furbo, e repugnante nella sua bassezza, e tutta quella mischia di schiavi, di servi e manigoldi – che meravigliosa galleria di ritratti e caratteri!
Però anche qui, come prima nella Trilogia, non sono le persone che rappresentano il vero centro del racconto. Il cozzo terribile di due mondi opposti, dei quali uno, sotto le sembianze della città antica, cinica e gaudente, città che muore tra la bellezza, tra i profumi inebrianti di rose e di incensi e tra i simposi, accompagnati dalle danze estatiche di donne lussuriose, deve cedere ad un altro, ancora nascosto nelle ombre taciturne delle catacombe, ma già abbagliante, già vittorioso, perché superiore. Ecco ciò che muove l’azione di questo misterioso dramma di anime, di menti e di spiriti innanzi all’ignoto di una fede nuova, tutta astratta nella sua concezione del divino, tutta piena di sacrifici e sofferenze e tutta in contrasto insuperabile colla vecchia fede degli avi…
Dal quadro sfolgorante di colori e passioni del «Quo Vadis?» Sienkiewicz torna ancora tra i suoi e scrive «I Cavalieri della Croce», l’ultimo della serie dei grandiosi suoi affreschi. Fu una nuova rivelazione della sua genialità, un nuovo segno della grande sua intuizione artistica.
Ispirato da un gravissimo avvenimento storico, il celebre romanziere seppe di ricostruire anche qui tutta una epoca, indovinando persino la sua lingua, completamente dimenticata nel grigiore medioevale dei tempi. Il soggetto, uno dei più drammatici momenti dell’eterna lotta slavo-germana, coronata dalla famosa disfatta del 1410, inflitta a Grunwald dall’esercito polacco-lituano ai terribili cavalieri della croce, rappresentava – è vero – già per se stesso una fonte magnifica per un’opera d’arte. Ma troppo scarso fu il materiale per la sua incarnazione e toccava piuttosto al genio creatore del poeta d’inventarlo e di fonderlo.

Anche nei «Cavalieri della Croce», come nella Trilogia e nel «Quo Vadis?», è la massa sconosciuta attorno alla quale si muove tutta l’azione del grande romanzo storico. Una moltitudine di tipi inventati, ma tutti vivi ed originali, dispersi sul fondo tetro di una mischia indescrivibile di due forze elementari , una delle quali deve soccombere all’altra per ragione divina do qualche legge suprema ed irrevocabile.
E, al di sopradi tutto ciò, la figura granitica del grande Jagellone, granduca lituano, e la mistica apparizione della regina polacca, sua sposa, nella penombra della cattedrale gotica, sono come un simbolo della sacra unione di due popoli affratellati, pegno sicuro della futura loro grandezza. Sono visioni che, contemplate una volta, non si dimenticano mai più…
Come un tragico messaggio viene la notizia della morte di Enrico Sienkiewicz nella sua patria desolata. L’ha abbandonata proprio nel momento quando più che mai ne aveva bisogno. La sua parola autorevole valeva troppo davanti alla gente che vedeva in lui il vivo rappresentante dell’anima e dello spirito del popolo infelice.
Se n’è andato coll’anima straziata , vedendo attraverso le lontananze questa sua terra tanto amata. La voleva vedere libera ed indipendente ed invece la vide soggiogata, piena di dolori, insanguinata ed affamata.
E come dei singhiozzi di un pianto, che spacca il cuore, ci vengono oggi le sue parole che, come Presidente del Comitato Generale per le vittime della guerra in Polonia, lanciò dal suo esilio ai popoli civili. – «Il nostro pensiero, il nostro lavoro e la nostra forza creatrice segnano con la loro impronta le più belle pagine della storia dei popoli; la nostra voce è sempre unita al coro immenso delle nazioni, e questa voce raggiunge spesso accenti sublimi.
«È dunque in nome della solidarietà umana, nel nome di una nazione rimasta fedele a questo principio, e in nome di Cristo testimone delle nostre sofferenze secolari che io rivolgo questo appello ai popoli civili. Secondate i nostri sforzi per strappare la nostra Patria alla più terribile disperazione; aiutiamo il villano a ricostruire il suo ricovero; diamo al lavoratore il pane che ristorerà le sue forze, il grano che gli renderà la speranza delle messi future. Possano le madri polacche rispondere ai loro bimbi affamati altrimenti che con lacrime; possa il popolo polacco sopravvivere nella plenitudine delle sue forze all’ora di questa prova suprema e attendere, con la speranza nel cuore, la prossima aurora della resurrezione».
ALESSANDRO KOLTONSKI
[ALEKSANDER KOŁTOŃSKI]


